di Antonio Devicienti
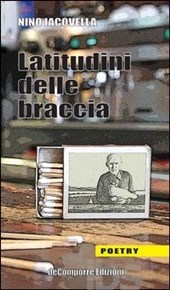 Latitudini delle braccia (deComporre Edizioni, Gaeta, 2013) è un libro convincente e compiuto, maturo e serio, in quanto in esso si attua un perfetto equilibrio tra temi ed espressione linguistica. Vi si riconosce uno stile asciutto, consapevole e controllato, privo di sbavature o di incertezze, chiaro risultato di una diuturna ricerca e di numerosissime, instancabili letture. Aggiungo inoltre che solipsismo, narcisismo, pose precostituite sono completamente assenti in questo lavoro, che la programmatica riflessione in versi, la presa di coscienza della realtà a noi contemporanea, l’adulta assunzione di responsabilità nei confronti del proprio tempo, il rifiuto di moralismi più o meno facili e tuttavia il giudizio storico compiuto e motivato sostanziano le dense pagine del libro, ne fanno un vademecum per chi voglia portare con sé la poesia quale compagna nell’attraversare i nostri giorni.
Latitudini delle braccia (deComporre Edizioni, Gaeta, 2013) è un libro convincente e compiuto, maturo e serio, in quanto in esso si attua un perfetto equilibrio tra temi ed espressione linguistica. Vi si riconosce uno stile asciutto, consapevole e controllato, privo di sbavature o di incertezze, chiaro risultato di una diuturna ricerca e di numerosissime, instancabili letture. Aggiungo inoltre che solipsismo, narcisismo, pose precostituite sono completamente assenti in questo lavoro, che la programmatica riflessione in versi, la presa di coscienza della realtà a noi contemporanea, l’adulta assunzione di responsabilità nei confronti del proprio tempo, il rifiuto di moralismi più o meno facili e tuttavia il giudizio storico compiuto e motivato sostanziano le dense pagine del libro, ne fanno un vademecum per chi voglia portare con sé la poesia quale compagna nell’attraversare i nostri giorni.
La metafora della POLAROID (Scatto di prova), titolo premesso al primo testo dell’intera raccolta, si ripeterà nel corso di tutto il libro e dichiara esplicitamente da un lato la volontà di “fotografare” i fatti, le persone, i luoghi, ma con il metodo della polaroid, quasi che la scrittura possa essere anch’essa uno scatto istantaneo autosvilluppante, dall’altro l’intento di fotografare ciò che è a noi contemporaneo (e vedremo in quale senso), i fatti mentre accadono (ma il progetto di Nino Iacovella è in questo caso molto più ambizioso e complesso di quanto facciano supporre le mie parole).
Il primo testo ricorda (e fotografa) la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ore 10,25:
Hai forse dimenticato le braccia / da qualche parte, in questa città, / dove puoi vedere ancora il fumo / denso dell’esplosione. Vedi, tutto / si compie all’altezza di un cielo / irraggiungibile. Eppure volevi / afferrarlo quel momento di cielo, / così, con la tua mano distaccata / da tutto il resto, un corpo ricaduto / a pezzi, il mosaico che pavimenta / i resti della stazione. È vero, / siamo qui, in tanti tra le macerie, / assieme alla testa di un cane / c’è come terra di carne sbranata // Nell’attimo prima che si compisse / lo scempio, eri lì ad interrogarti / sulla faccenda della vita, senza / aspettarti nulla, nessun fragore. / Ed eri solo a due passi dall’innesco, / vicino a chi avrebbe deciso le sorti / del vuoto d’aria che ti avrebbe preso / per alleviarti dall’insostenibile / peso delle braccia // Nemmeno la tua solitudine poggia / più sulle proprie gambe. Adesso è lì / mescolata a terra indistinta tra / lamiere storte, viscere e sangue (pag. 19).
Nella pagina precedente questo testo sono riportate le stupende parole di Mario Giacomelli: Nelle mie foto vorrei ci fosse una tensione tra luce e neri ripetuta fino a significare. È proprio quello che viene attuato nel testo poetico testé citato: subito, in attacco, riconosciamo il Leitmotiv delle braccia (il titolo del libro trova dunque immediatamente la propria giustificazione), braccia, mani, pezzi del corpo dilacerati dall’esplosione, mentre Iacovella identifica l’io lirico con la voce di una delle vittime che parla ad un’altra vittima, i brandelli del corpo che formano come un mosaico sul pavimento della stazione distrutta e la testa del cane (la bomba ha colpito tutti e tutto, animali, cose, persone) e quel verso, c’è come terra di carne sbranata, eloquente e terribile, vero e irreversibile è come aggettato sulla strofa successiva, là dove si mescolano il destino del singolo, che medita sulla propria esistenza e sulle proprie aspettative, ed il destino comune, stavolta deciso da una bomba, dal terrorista che ha attivato l’innesco. Ecco uno dei punti alti e indimenticabili del libro: non c’è elegia, non c’è lamento, non c’è patetica protesta, ma l’oggettività di un incrociarsi delle storie individuali con la storia collettiva, la constatazione misurata e rigorosa di quanto accaduto. Trovo peculiare la punteggiatura: sulla misura più o meno variata dell’endecasillabo, il punto fermo tende a marcare forti cesure all’interno del verso, mentre esso manca tra strofa e strofa e la pronuncia, netta, è ritmata dagli enjambements e definita dalle virgole e dai punti fermi.
La sezione seguente è introdotta da POLAROID (scatto di famiglia) e contiene quello che si potrebbe ritenere un vero e proprio poemetto (Linea Gustav), ha il suo centro geografico in Guardiagrele, il paese in provincia di Chieti dove Iacovella è nato e dove lo riconducono la memoria della propria famiglia emigrata nel Nord (Nino vive e lavora a Milano) e la memoria resistenziale. Aperta da una citazione da Gian Mario Villalta (Viene in mente la Singer di mia madre / (di sua madre) e che erano migliaia / uguali nelle camere d’Europa. / Migliaia. A pedali, a manovella. Mani / e piedi, gesti uguali, inutilmente) e da un’immagine di Lucio Orlando che raffigura una donna meditabonda davanti alla propria macchina da cucire, la sequenza rimemora episodi della guerra, della sofferenza della popolazione civile e della resistenza lungo la Linea Gustav. La chiara convinzione che vi è sottesa è che non bisogna dimenticare, ma raccogliere l’eredità resistenziale, perché siamo, senza retorica, figli di quel sangue versato e perché la Resistenza non fu soltanto delle bande partigiane, ma di un’intera popolazione, solidale nella sofferenza e nel rischio, capace di sentirsi ed essere comunità.
Vorrei cambiare nome agli inverni / tenendo più stretto il ricordo del freddo / il gelo nelle dita dei soldati // Veder sparare ancora i tedeschi / a denti serrati dall’alto del muraglione / con occhi che / spezzano a vivo / la coda inerme degli sfollati // E cercarvi lì, tra i vecchi a coprire le madri, / le madri come rifugi per sagome minute / (tra il seno e la spalla, insenature / come porti per piccole teste / spaurite nella burrasca) // Sul paese come un’ombra la linea Gustav, / tracciato d’inchiostro sulle rovine, / il confine tra chi si butta a terra / prima o dopo lo sparo (pag. 31).
Si delinea quindi da subito una direzione di pronuncia di nuovo chiara, precisa, tutta fatti e persone che agiscono, una poesia che dice il passato, ma anche perché esso è a noi contemporaneo, una sprezzatura del verso che ha imparato molto da Pasolini, da Fortini, da Roversi, azzarderei anche da Scotellaro e che, penso, potrebbe trovare un interessante dialogo con la poesia di Giovanna Frene, di Maria Grazia Calandrone, di Franco Buffoni, di Luciano Cecchinel e di Pierluigi Cappello quando questi autori tornano a meditare sulla storia italiana, portando la scrittura in versi nell’inferno stesso di quella storia così contraddittoria, ancor oggi non condivisa, ancora oggi suscitatrice di contrapposizioni. Direi che la pronuncia limpida e diretta di Iacovella vuole fare piazza pulita anche di quelle torbide, non sempre sincere prese di posizione che tendono a rendere le vittime “tutte uguali”. Infatti: Gli anni nascosti dietro la collina / ritrovati all’apice di un giorno: / adesso siamo il recinto di un giardino / dove nitido si scorge il filo spinato // A stringere questi nodi di memoria / è come mostrare il petto al nemico, / volersi ferire, rovesciando colori a terra, / far finta che non siano solo sangue // Con mani legate siamo in attesa / che si assesti di nuovo, colpo su colpo, / il battito sulla raffica // Del cuore rimane un proiettile irrisolto, / una traccia murale sfarinata. // Mentre la bocca è contro il muro / con la lingua si scioglie un sapore / di sabbia e calce viva che sa ancora / dell’attesa breve dei fucilati (pag. 33).
La scrittura rivive l’esperienza degli internati in attesa della fucilazione, un linguaggio non patetico né sentimentale vuol stringere questi nodi di memoria, il nemico c’è ancora, anche la nostra bocca sente un sapore / di sabbia e calce viva: sottolinerei come l’incisività delle immagini e della dizione venga raggiunta in modo apparentemente spontaneo, senza sforzi né forzature, altro grande merito di questa scrittura la quale invece, certamente, ha conosciuto anche un impietoso labor limae, un lungo e doloroso arrovellarsi su certe clausole, su certe scelte di contenuto e di forma. Una tale maturità espressiva è, molto spesso, risultato di un lunghissimo apprendistato, di un sagace studio sul fare poesia.
La guerra ritorna così anche nei sogni di un uomo e poeta nato nel 1968 (Questa notte, se la mia presa sarà forte / più lunga di un abbraccio, / è perché ho sognato che ti tenevo a stento / mentre i colpi di mortaio sibilavano in aria // Vedevo l’ospedale da campo che si allontanava, / sembrava irraggiungibile: eri ferita come mio padre / e io non volevo lasciarvi morire, pag. 36: e io non volevo lasciarvi morire – semplice e magistrale clausola finale, umanissima e priva di enfasi, perfetta dal punto di vista compositivo ed espressivo) o nelle parole di un caduto nella battaglia di Nikolajewka (pag. 39). E ci sono i civili morti nei bombardamenti, il giovanissimo Trentino La Barba, legato a testa in giù ad un albero e torturato a morte, ma che non rivelerà i nomi dei suoi compagni, gli insorti di Lanciano il 5 ottobre 1943 (osservo: a meno di un mese dall’8 settembre …) e la madre di Vincenzo Bianco che riporta il corpo di suo figlio a casa sostenendolo sulle proprie braccia: Martiri del 6 ottobre // Sai che non riesco a vedere il silenzio, / la testa china di una città / che ci fa strada, / che ci vede insieme io e te / Enzo, mio figlio che torna per sempre / tra le braccia della madre // Così ti ho tenuto stretto lungo il percorso / sino alla porta di casa / senza dire una parola / senza alcun pianto // Avevo quasi perso l’uso delle braccia (pag. 44).
La scelta espressiva di Iacovella, coerente nel corso dell’intero libro è quella di una cadenza ritmica e lessicale asciutta, come ho subito detto all’inizio, priva di orpelli e di intellettualismi, commossa nella misura in cui partecipa degli accadimenti, ma senza enfasi, senza teatralità. In questo caso, poi, l’asciutto dettato s’innesta sulla tradizione popolare dell’Addolorata e della Deposizione (ma quanto laica e terrena è la madre sofferente delle Latitudini delle braccia! E il titolo del libro si conferma necessario e davvero ben scelto, trattandosi qui delle pietose braccia della madre, le stesse che avevano tenuto e nutrito il figlio bambino e che ora ne riportano, fino al limite del cedimento, il corpo ucciso verso casa). Mi torna in mente l’Epitaffio di Ritsos, il poema dedicato alla memoria del sottotenente caduto in Albania di Elitis e l’epigrafe dettata da Piero Calamandrei per i fratelli Cervi, in una linea di continuità che vede nella madre, voce di tutto un popolo, colei che dà la vita e che, atrocemente schiacciata tra strazio e pietà, è costretta a dare sepoltura al figlio assassinato.
L’ultimo testo del poemetto, Linea Gustav, rievoca un aprile di molti anni dopo la guerra, una scampagnata per Pasquetta, intuisco verso i luoghi che avevano visto partigiani e tedeschi fronteggiarsi: Quel giorno erano così belle le nostre ragazze / nei loro jeans attillati, e non bastava la bellezza / dell’orgoglio per desiderarle, / loro avrebbero già scelto con chi stare, / mentre noi ragazzi dentro buste di plastica / avevamo già più vino che pane – terza strofa a pag. 45; durante la gita i ragazzi e le ragazze, che non hanno vissuto la guerra, ma che l’hanno sentita raccontare, si trovano comunque a condividere una memoria collettiva, suggestionati dai luoghi. Mi ha particolarmente colpito e commosso quest’idea, forse perché mi trovo a vivere un tempo nella storia del mio Paese in cui proprio i concetti di comunità e memoria collettiva sono stati erosi e distrutti; scrive Nino nella penultima strofa: Chiaro era il cielo di quell’aprile / quando siamo stati figli e lo saremmo stati / sempre, di coloro che toccarono la guerra / a mani nude prima di saltare per aria, / delle madri rimaste tumulate / nell’esplosione del rifugio, / di corpi rimescolati nella terra / pur di vederci rinascere.
Le latitudini delle braccia sono anche quelle della memoria accolta e condivisa, di una storia in cui riconoscersi e in nome della quale accedere alla vita adulta (nella seconda strofa l’autore scrive: Così era l’alba del Lunedì di Pasqua, / con le nostre madri rimaste in un’attesa / chiusa all’altezza dello stomaco, come se noi / davvero fossimo stati capaci di partire); non a caso le ragazze, sulla strada del ritorno, appoggiano il loro capo sulla spalla di chi non si era arreso alle bevute, i sopravvissuti, / quelli che non erano rimasti sull’erba a vomitare, perché lucidità e consapevolezza traghettano gli adolescenti nella loro maturità di cittadini.
La pagina 47 reca un’altra illustrazione di Lucio Orlando raffigurante Zì Nicole che tiene in braccio una gallina ed ha alle spalle un vasto paesaggio di acque e di colline, esattamente la medesima illustrazione che, sulla copertina del libro, funge da coperchio di una scatola semiaperta di fiammiferi appoggiata forse a terra, forse su di un tavolo: è la memoria che, come un fiammifero, si accende, arde e rischia di spegnersi dopo pochi secondi se la fiamma non viene alimentata?
La nuova sezione è introdotta da un’altra POLAROID (scatto di famiglia) intitolata La strada per san Donato di cui riporto la seconda e le due ultime strofe: raccoglieremo dal sentiero / le ossa, forse i denti dei caduti / per farne amuleti, o croci / sull’erba che sa di cenere // (…..) // Poi con piccole mani deporremo un segreto / in un catino di smalto e ruggine // Starà in quel posto, sino a quando nell’aria / ci sarà qualcosa da respirare, / aspettando il giorno in cui tornermo / a scavare in fondo al tempo, / per ritrovarlo. Scavare: forse con la penna, come memorabilmente diceva Seamus Heaney ed in ogni caso ripercorrere antichi sentieri, con la pietas dei vivi raccogliere i resti dei morti, non innalzare loro retorici mausolei, ma approntargli umili, durature nicchie dentro il ricordo. Una terra come carne è quella che abitiamo (titolo della nuova sezione che, come la precedente, può essere letta anche come breve, conchiuso poemetto) e che si rivela strazio dei corpi lacerati e maciullati dalla battaglia, quando, cessati i combattimenti, si scava per raccogliere i resti dei caduti e dar loro sepoltura o per portar via i feriti; la mente del lettore non può non pensare anche alle riesumazioni dei corpi dalle fosse comuni e alla strage della Stazione di Bologna, altro asse tematico coerente del libro:
Tastando l’argilla / (a lato, un lembo di camicia affiora a piene mani) / ecco in vista i corpi martoriati, farsi parete / e muscolo della fossa // (….) // La rabbia brandisce il martello del dolore / la forza necessaria per frantumarlo in pianto (pag. 59); La ricerca del cielo svuota le ossa / spoglia a vivo delle braccia // Del sogno pindarico rimane la sola forza / delle esplosioni che potrebbero librarci in aria (pag. 62). Vedo anche in questi versi l’indicazione concreta per una poesia che possa essere ancora anche lirica, a patto che eviti piagnistei, sospiri, effusioni sentimentali, ma, leopardianamente, guardi dritto negli occhi il dolore e la morte; c’è, a questo proposito, a pag. 119 una strofa illuminante, l’ultima del testo intitolato Cenacolo: A volte torno quel bambino che piange / quando si spegne la luce, / e rivedo mia madre nel dubbio: / avrà fatto bene a non nascondermi la paura / a farmi vedere l’oscurità, il buco nero del corridoio / dove tutti sappiamo bene che il lupo / spalanca ancora le sue fauci.
Mi scuso per la rapida anticipazione (sulla quale mi soffermerò più avanti contestualizzandola meglio) e torniamo ora a contemplare un’altra Polaroid: è il ferragostano rituale della carne alla griglia che, però, svela ai commensali sbigottiti il rito di sangue che è il cuocere e l’ingerire le carni di altri esseri viventi: la lingua asciuga un sapore liquido, / lo stesso sangue che pulsiamo (pag. 67), perché il tema della nuova sezione, Food for the ants, sono proprio i riti, spesso sanguinari e sanguinosi se ci si sofferma a riflettere, dell’esistenza metropolitana. Lo sfondo è Milano, ma potrebbe trattarsi di qualunque centro urbano industriale del nostro tempo; tornano alla mente i testi di Gianni Montieri, ma anche di Pasolini e di Volponi, di Erba e di Sereni; sia chiaro: Iacovella ha raggiunto una sua dizione personale e del tutto riconoscibile, non imita, ma, evidentemente, ha assimilato le voci cui accennavo: egli non descrive la realtà urbana e la quotidianità, non ricorre alla mimesi del parlato, non “si arrende al labirinto”, come avrebbe detto Calvino, ma tale realtà e tale quotidianità focalizza tramite un obiettivo che è una coscienza la quale definirei “illuministica”, un illuminismo integro nella sua coscienza storica, sociale, politica ed economica. Mi sembra, ad esempio, che il tema del corpo sia un asse portante di questa sezione, che si tratti del corpo malato (vedi Gastroscopia a pag. 73) o del corpo che entra in un locale chic di Milano (Radetzky a pag. 74) per sentirsi totalmente estraneo a quell’ambiente alla moda, da quello stesso ambiente respinto; può essere anche la sensazione di assedio e di vaga claustrofobia che si può avere nel proprio appartamento condominiale (Over a pag. 76), così come la necessità di giustificarsi per essere entrato in un bar a proteggersi dalla pioggia e dove Il barista è un Dio senza parola / che raggela tutti dal banco (quinta strofa a pag. 77: c’è una reminiscenza della celeberrima Tabaccheria di Pessoa?). Il tema del corpo (personalmente lo definirei “corpomente”, rimanendo, ancora leopardianamente, inscindibile la sfera corporale e sensitiva da quella intellettiva) viene sviluppato in rapporto allo spazio, il quale ultimo è quello urbano e pure quello degli interni urbani, risultando parallelo all’interessante riflessione sempre sul corpo di Biagio Cepollaro nel libro Le qualità (La Camera verde, Roma, 2012), ma anche a Marco Giovenale che in Shelter (Donzelli, Roma, 2010) tematizza proprio la connessione tra corpo e luogo, tra protezione e minaccia, tra pericolo e rifugio, mentre Marina Abramović ha del corpo al tempo stesso tema e medium della propria arte.
Il penultimo testo omonimo della sezione è ispirato al verso It seems like the ants love me, why they do? del gruppo indie rock “Yuppie Flu” (i numerosi testi che in questa parte della raccolta recano un titolo in inglese fanno supporre che i versi di Iacovella si potrebbero leggere con un sottofondo di musica rock alternative, al tempo stesso riferimento al forzato ingozzamento muscale cui l’abitante della città è costretto non appena entri in un centro commerciale, in un negozio e, sempre più spesso, persino in un ufficio ed anche invito a scegliere come “colonna sonora” proprio quel genere di musica estranea alle grandi etichette commerciali, critica ed alternativa alla cultura di massa); Food for the ants mette in scena il destino di un aspirante suicida il quale, ogni sera, “prova” la dinamica del salto nel vuoto, finché un giorno si lancia nel vuoto, un corpo solitario piombato giù, / un ingombro al senso di marcia delle persone // La gente stenta a credere che / l’intervento di rimozione / sia così complicato / sia necessario tutto quel rituale / di sirene e lampeggianti, / che un corpo muto e sordo / possa ancora dire qualcosa, / o ascoltarli nelle loro rimostranze // O farsi vedere, magari più in là, lontano dalla luce, / dove è più facile scansare la mano aperta / che affiora dal telone (pag. 87).
Rinvengo qui un’altra, altissima qualità di questo libro: l’immediatezza di dettato e d’immagini, una sorta di “partito preso delle cose” dovuto alla totale consapevolezza da parte di Iacovella che, nella realtà degli umani, tutto è linguaggio, comunicazione: il corpo, muto e morto, continua a dire qualcosa (qui la solitudine, la disperazione, il senso di abbandono) e solo chi vive nell’inconsapevolezza può sorprendersene (“la gente” senza volto, coloro che vengono connotati da questo sostantivo così generico ed anonimo). La mano aperta / che affiora dal telone si aggiunge a sigillo del testo, ancora una parte del corpo che viene isolata e perciò maggiormente messa in evidenza, terribile ed eloquente nella sua icasticità.
Ponte tra la presente sezione e la nuova Polaroid è Ipermercato, dicembre (pag. 88), per poi approdare ai testi raccolti sotto il titolo Un uomo tre per due, originalissima sequenza dedicata, appunto, agli spazi degli ipermercati. Esergo da Marc Augé: Lo spazio del non luogo non crea né identità singola né relazione, ma solitudine e similitudine. Mi soffermo sulle citazioni apposte in apertura di ogni sezione anche per sottolineare che siamo in presenza di un libro colto (attenzione: non ostentatamente colto, ma necessariamente colto, premessa irrinunciabile se si vuol scrivere in poesia in modo non ingenuo né dilettantesco) e che l’architettura di Latitudini delle braccia è precisa, perfettamente calibrata e progettata, in un’illuministica volontà, appunto, di controllare la materia del discorso, di dominarne l’eventuale magmaticità, all’interno della capacità di partecipare emotivamente a tale materia, pur conservandone la giusta e necessaria distanza.
Riporto alcuni passaggi: Ma le parole di saluto sono inceppate / tra il rollio della scala mobile / e il reparto delle giostre per l’infanzia // dove il gioco del braccio meccanico / è come un monito per i peluche, / una presa che oscilla nel vuoto, / una forza sgraziata che non sa stringere (Ipermercato, dicembre pag. 88).
Chi avrebbe mai pensato che si potesse trarre poesia dal braccio meccanico che cerca di pescare i peluche? Si tratta di un braccio (di nuovo!), ma che non sa afferrare, che stavolta è senhal di un fallimento, perché un braccio, e meglio ancora le braccia sono fatte per abbracciare, salutare, prendere, portare, lavorare, evidentemente anche scrivere.
Intanto che giriamo a vuoto / siamo insetti ingannati dal cristallo: / cerchiamo una via d’uscita, accecati, / tutta una vita controluce (pag. 98).
Ora la folla sembra fluido, / colata fossile che poi coagula / all’entrata / (…..) / Dalle scale mobili vengono incontro / facce fuori fuoco, un corpo dietro l’altro / come molecole sciolte dai legami / (……..) / tutto appare nella forma liquida dei corpi (pag. 99).
Qui la poesia è, di nuovo, presa di coscienza ed istituendo comparazioni e metafore può oggettivare tale situazione di cieca ed inconsapevole massificazione.
Ecco, siamo dentro l’immagine: / la videocamera riprende i passanti, / merce che infrange l’ordine delle vetrine / (……..) / Prossimi alla soglia del proprio volto / siamo corpi accecati dall’indugio: / né cose che sanno andare via, / né cose che sanno restare (pag. 101).
Oramai prossimi al rumore delle casse, / facciamo gruppo, un branco che mostra i denti / al vuoto circostante (pag. 103).
Il poeta è dentro la folla che a sua volta si aggira, apparentemente (ma solo apparentemente) libera nel ventre fagocitante dell’ipermercato, in realtà incanalata ed indotta a ripetere gli stessi gesti, acquistare la stessa merce, officiare gli stessi riti quale possono essere, aggiungo io, l’insacchettare la spesa, inserire la carta di credito nel lettore, ritirare lo scontrino … Ma in questo caso il poeta porta dentro di sé una vigile consapevolezza, è capace di vedersi come dall’esterno, nutre desideri autonomi e non controllabili dal sistema consumistico: Vorrei aprire le porte di questo luogo / come se stessi per aprire le finestre della mia camera, / fare entrare luce più calda dei neon / e sentire le cose riempirsi d’aria // gonfiarsi, come se si potesse rimarcare / la deformità degli oggetti, vedere sorrisi slabbrati / dal dolore, ma con occhi che tornano a guardarsi (pag. 104).
Forse, allora, i bambini possono ancora sfuggire al condizionamento dell’ipermercato, essere anche per gli adulti forza liberatrice: E i bambini nel dolore / che avrebbero voluto: / lanciarsi nella corsa, farsi prendere / in un abbraccio duraturo, / da far male / (…….) / Fuori la notte costruisce muri / le case in fondo al viale, / un rigurgito di automobili annuncia / l’inferno della tangenziale (pag. 106).
Ed approdiamo all’ultima sezione, Cortocircuiti. Parole di Giorgio Caproni: … perch’io nella notte abito solo, anch’io, / di notte, strusciando un cerino sul muro, / accendo cauto una candela bianca nella mia mente … Trova dunque in questi versi un’ulteriore giustificazione l’immagine di copertina, la scatola di fiammiferi, soprattutto se si considera il fatto che i “cortocircuiti” sono quei momenti nell’esistenza (la morte di una persona cara, una malattia, ma anche l’attesa di un figlio) che ci sorprendono interrompendo l’abituale fluire dell'”elettricità”, esponendoci ad inattesi momenti di buio o di penombra, di silenzio e d’incertezza, spalancandoci davanti ed intorno un abisso sempre presente, ma che rimuoviamo tramite le ingenue furberie che la mente escogita per difendersi dall’angoscia: Cala il buio come un taglio: / solo nero dentro le stanze, / suoni d’allarme nell’aria, / le nostre frasi interrotte // Con uno strappo improvviso il telone / della scenografia mostra lo squarcio / della finzione // Prima che il miracolo della vista / torni a riappropriarsi dei corpi / sembriamo come morti // la vita rimane più sottile // non sappiamo sino a quando (Cortocircuito, pag. 115).
Momento angoscioso ed imbarazzato in cui si rivela la finzione che, spesso, sottende il nostro esistere, ma anche momento nel quale si ascolta la città sin dentro le ossa (Ascensione, pag. 116) e nessuno sa dove stiamo andando (Fase lunare, pagina seguente), Fiutiamo l’ultima ombra, le tracce / in ogni angolo della stanza / prima che torni la luce, un ordine tra le cose (Entropia, pag. 118), ma Tu non hai paura, sai che in grembo / un figlio si nutre ancora ad occhi chiusi / tocca le pareti del corpo / in cerca di calore (Cenacolo, pag. 119). Siamo esattamente nel luogo che avevo anticipato poco fa e direi che in questo libro, discreta ma determinante, emerge la presenza della femminilità-maternità, connessa con il tema del corpo e della vita, della famiglia stessa; se il padre è custode della memoria familiare e collettiva, la madre (o dovrei dire le madri presenti nel libro, non solo quella dell’autore) e la compagna sono portatrici del principio sia biologico che intellettuale della vita, principio che non si sottrae alla consapevolezza del lupo annidato nell’ombra a fauci spalancate e che è capace di avere memoria ancestrale della nostra origine di umani.
E c’è pure, mi sembra d’intuire una delicatissima lirica d’amore che potrebbe essere rivolta sia alla compagna di vita che alla madre, una movenza discreta e colma di pudore, stupenda ed ammirevole: Le braccia mi tremano ogni volta / prima di toccarti (Sovrapposizione, pag. 120) e La materia del buio è palpito di vene / (…..) // A nudo sotto i piedi come radice / mi nutro in sogno di ogni tuo pensiero // I tuoi occhi mi riportano nei posti / dove non sono mai stato (Contatto, pag. 123).
L’ultima polaroid ci riconsegna al ritmo della vita quotidiana: e il letto è già discesa dalle scale, / innesto tra la folla / (…..), ricomincia un’altra giornata di lavoro, si prende il treno, poi la sera si ritorna a casa e Le finestre rimangono aperte come spiragli (pag. 127), spiragli sul prossimo libro di poesia, chioso in conclusione, bellissima immagine di apertura, attesa e disponibilità, giusto ed appropriato sigillo per un libro già di per sé aperto sul mondo e sulle persone, sulla storia e sul linguaggio, del tutto coerente fin dal suo titolo nel ricorrere dell’immagine delle braccia, le cui latitudini, pur variando, sono dense di significato, di memoria, d’azione, di poesia, dal momento che la poesia di Iacovella sa, nell’epicentro della metropoli fagocitante, della storia violenta e dell’abisso esistenziale far scorgere momenti di luce, d’amore, di condivisione.
* Il presente contributo è già apparso in una versione più ampia sul blog “Compitu re vivi”
Ho creduto in questo libro ancor prima che nascesse in forma compiuta. I motivi sono nella prefazione che ho firmato: poesia corale che, a partire dalla storia,raggiunge i suoi vertici nella quinta, caravaggesca sezione, dove protagonista è la luce. Un linguaggio mimetico, metamorfico, che non strizza mai l’occhio al lettore e rischia a volte la giusta oscurità. Il materno come filo rosso delle cinque sezioni, con le radici nella contingenza e lo sguardo proteso all’eternità. Una poesia civile che è prima di tutto poesia della vita e della sua tragedia. Mi piacerebbe – e credo sarebbe corretto – poter essere inserita nei tag… Alessandra Paganardi
Grazie ad Antonio per questa lettura così profonda ed articolata.
Grazie ad Alessandra per aver creduto ancor prima del nascere e altro, altro ancora.
Nino
Grazie a voi! ale